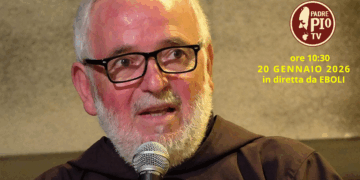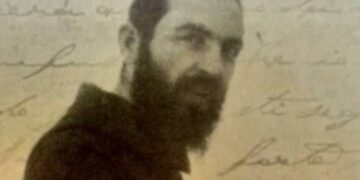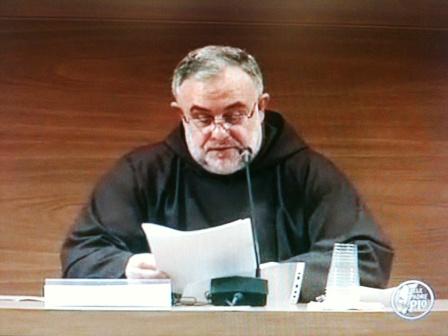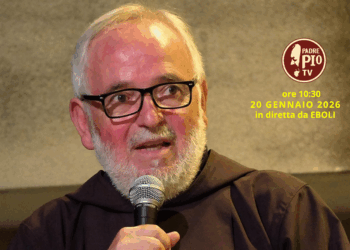"Il confessare come dialogo salvifico” è stato il tema della conferenza che ha aperto la quarta giornata della Settimana Internazionale della Riconciliazione. L’intervento tenuto da padre Sabatino Majorano preside emerito e docente presso la Pontificia Accademia Alfonsiana ha approfondito la «responsabilità dei ministri della misericordia infinita di Dio». Una responsabilità da vivere con fiducia, «perché radicata e resa possibile dall’anticipo di grazia che è il nostro sacerdozio». Una responsabilità che «deve concretizzarsi in un impegno di formazione continua per rispondere costruttivamente a situazioni rese sempre più complesse dal rapido cambiamento della nostra società». Sarà allora possibile realizzare «uno stile di confessare che sia veramente un dialogo di salvezza per chi si avvicina al sacramento». Tre parti in cui si è articolata la riflessione di padre Majorano, nella quale si è lasciato «guidare, in maniera particolare, dall’insegnamento di S. Alfonso, il Patrono dei confessori e dei moralisti». Perché possa essere effettivamente “dialogo di salvezza” che fa incontrare la misericordia sanante e liberante di Dio, «lo stile del nostro confessare – ha detto padre Majorano – deve essere determinato dal convincimento che il nostro compito, come scriveva S. Alfonso, è “officio di carità, istituito dal Redentore solamente in bene delle anime”». Una responsabilità quella del sacerdote «che è soprattutto quella di padre che accoglie e di medico che sana». È la stessa visione di S. Alfonso che permette di concretizzare queste indicazioni: «a cominciare dalla maniera nella quale egli presenta i diversi uffici del confessore “padre, medico, dottore e giudice” e dalla maggiore attenzione e sviluppo che egli dedica a quello di medico». Ascoltare significa guardare le cose dall’angolazione del penitente: «non per legittimare ciò che non è possibile legittimare, dato che la carità chiede sempre di chiamare il bene e il male con il proprio nome, ma per cogliere l’effettivo valore di ciò che si è vissuto e così individuare i passi effettivamente risolutivi». Occorre invece ascoltare prima di tutto. «Solo così la verità non verrà percepita come imposta dall’esterno, ma frutto di una “maieutica” che fa emergere lo Spirito che è già all’opera anche nel peccatore più incallito». L’ascolto misericordioso che porta a considerare il peccato innanzitutto «come malattia che contagia e debilita e da cui la confessione deve aiutare a guarire». Il dialogo con il penitente «va svolto da medico, più che da giudice», e perciò mira innanzitutto ad una corretta diagnosi: «il confessore, affine di ben curare il suo penitente, deve per prima informarsi dell’origine e cagioni di tutte le sue spirituali infermità». Solo così sarà possibile «far la correzione, disporre il penitente all’assoluzione ed applicargli i rimedi».
Giorno della Memoria: dalla Shoah un monito per l’Europa e il mondo
A 81 anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, il Giorno della Memoria ci invita ad una profonda...